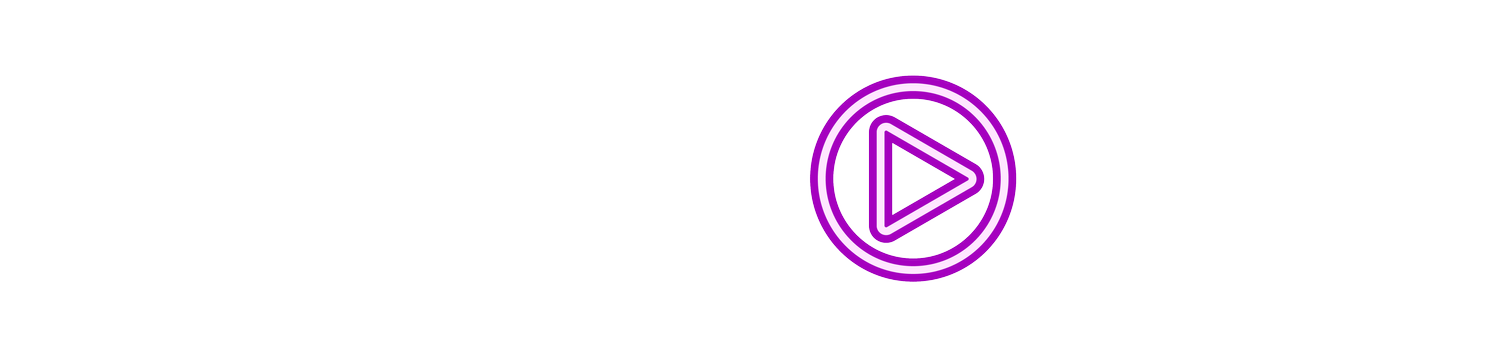Intervista a Sofia Assirelli – Episodio 2: scrivere serialità streaming
Continua l’intervista a Sofia Assirelli, sceneggiatrice televisiva attiva tra Rai, Mediaset e Netflix. Dopo aver ragionato su cosa significa essere headwriter in Italia – Sofia Assirelli ha ricoperto questo ruolo, insieme a Giampiero Rigosi, per la seconda e terza stagione di La porta rossa (2017-2023) – prosegue la nostra riflessione sulla scrittura seriale nella produzione italiana contemporanea.
Tu hai scritto anche episodi di serie non create da te, come nel caso dell’Ispettore Coliandro. Com’è scrivere dei personaggi che hanno già una lunga storia e un modo di esprimersi e di agire ormai così tanto caratteristico?
Questo è proprio il mestiere, ed è una cosa su cui io punto tanto. Quando sei tu a creare la storia hai necessariamente uno sforzo in più da fare, che è quello di immaginarti i personaggi e il mondo. Quando entri in una serie che esiste già, la tua capacità sta nell’entrare in quel mondo e non far vedere che ci sei entrato. Nel senso, è proprio sbagliato se si fa vedere la differenza. È ovvio che un po’ di cifra stilistica si può dare, ma il tuo compito è entrare dentro la psicologia di personaggi che esistono già e farli agire in situazioni nuove. Allo stesso tempo, il tipo di storia che proponi deve adattarsi a quel mondo. Nel caso di Coliandro, quei personaggi sono fatti talmente bene che, se riesci a comprenderli intimamente, te lo suggeriscono loro cosa farebbero. E a me piace molto questa cosa.
Lavori molto anche con Netflix. Rispetto alla produzione generalista, cosa cambia, a livello di scrittura e di storytelling in senso lato, quando si lavora ad un prodotto per una piattaforma?
Fino a qualche tempo fa ti avrei detto che non cambia niente, perché in fondo i princìpi sono gli stessi, cioè devi comunque interessare, devi comunque incuriosire il pubblico. In realtà un minimo di differenza c’è. La cosa che caratterizza tutte le serie, che siano verticali o orizzontali, è il ritorno, il ritorno di quel mondo e di quei personaggi. Nel caso di una serie sulla televisione generalista, devi cercare di far ritornare il pubblico una settimana dopo, quindi devi scrivere un finale di un certo tipo.
Nella scrittura streaming è un po’ diverso. Nello streaming c’è molto la necessità di agganciare presto, di catturare da subito l’attenzione, di più che in una serie generalista, perché il rischio che il pubblico molli la visione è più elevato. A parte questo, i meccanismi sono simili, ciò che muta – continuamente – sono le esigenze editoriali. Tuttavia non c’è un’esigenza “streaming” e un’esigenza “generalista”, anche perché le piattaforme streaming oggi stanno facendo una programmazione in parte anche molto generalista.
Quanto è presente Netflix in fase di scrittura?
Dipende da progetto a progetto, e anche da chi ha avuto l’idea originale. In generale, tuttavia, il confronto editoriale in fase di scrittura non è una cosa che riguarda nello specifico solo Netflix, ma caratterizza proprio la scrittura seriale. Come dicevo, la serialità si basa sempre su strutture editoriali complesse e su lunghi confronti. Nel caso della Porta rossa c’è stato un confronto continuo con Rai, perché inizialmente era stata pensata per Rai 1, e non era facile trovare un equilibrio tra quella che era l’anima gotica del progetto – che ha un fantasma come protagonista – e l’esigenza di un pubblico largo come quello di Rai 1, e molto del percorso editoriale è stato incentrato su questo. Solo alla fine, quando già era stata girata, si è deciso di spostarla su Rai 2.
E sapendo che la serie sarebbe andata in onda su Rai 2, nella scrittura delle stagioni successive avete spinto più verso l’ambiguità e il noir?
In generale scrivere una seconda stagione è molto diverso dalla prima. Sapevamo che andava su Rai 2, ma sapevamo anche di avere un pubblico che ci aspettava, mentre per quanto riguarda la prima stagione non eravamo assolutamente certi che succedesse, anzi! Questo significa che da una parte abbiamo capito che a quel pubblico piacevano le trame anche molto complesse che avevamo intessuto nella prima stagione – avevo molto riso quando avevo letto il commento di uno spettatore stupito che diceva che non era una serie “ironing”, ovvero una serie che si può guardare mentre stiri – e quindi abbiamo spinto ancora di più le tonalità noir e la complessità della trama. Tanto che per parte del pubblico è stato troppo. Su Facebook c’erano tanti che commentavano che non si capiva nulla, mentre su Twitter in molti erano felici degli intrighi sempre più complicati. Alla fine buona parte del pubblico è rimasta.
Data l’importanza che RaiPlay ha oggi nell’ecosistema della Rai, le scrittura delle serie per Rai si sta adattando alla distribuzione streaming?
Non saprei, sicuramente ha aperto nuove possibilità per serie che prima avrebbero più faticato a trovare uno spazio o un pubblico nel flusso della televisione generalista. Anche il fenomeno Mare fuori è molto più legato a RaiPlay che alla messa in onda su Rai 2, probabilmente perché ha un pubblico più giovane, molto più legato alla fruizione streaming. La porta rossa è andata molto bene anche grazie a RaiPlay, che era ai suoi albori, perché era una serie non facilissima da seguire e RaiPlay dava agli spettatori la possibilità di riguardare le puntate. Noi abbiamo scritto episodi da cinquanta minuti, con un’identità molto precisa, pur sapendo che ce ne sarebbero stati due a serata, perché abbiamo pensato anche allo streaming e alla messa in onda internazionale, dato che all’estero non hanno necessariamente un palinsesto della prima serata strutturato come il nostro.
Riguardo al rapporto tra televisione generalista e streaming, un altro esempio che mi viene in mente è Gerri, che è il mio lavoro più recente. Era stata pensata per Rai 1 e poi, un mese dopo la messa in onda, è andata anche su Netflix. E devo dire che è andata molto bene sia con il pubblico generalista sia con quello streaming.
Per concludere, ti faccio una domanda sui tagli al Fondo Cinema e Audiovisivo annunciati per il 2026. Questa situazione che impatto ha sul lavoro degli sceneggiatori?
Impatta tutta la filiera, quindi anche su di noi. Ci siamo anche interrogati su questo, perché a volte, quando facciamo le riunioni degli autori, spesso parliamo di argomenti come il tax credit e i tagli, però noi saremmo autori, non sono cose che in teoria dovrebbero riguardarci direttamente. E invece sì, perché ovviamente se tutto il comparto viene tagliato ne risentiamo anche noi. Io ho notato più tardi il rallentamento che c’è stato negli ultimi anni, perché lo sviluppo dei progetti continuava, però era strano, perché non si arrivava mai in fondo, era sempre un girare a vuoto. Quindi a volte ti fermavi, a volte continuavi a modificare all’infinito per trovare delle strade.
Ora, con i tagli previsti, la situazione può andare solo peggiorando. C’è troppo spesso lo stereotipo che la nostra sia un’industria costituita di privilegiati, che attende solo l’assistenzialismo dello Stato. Il sistema dei finanziamenti aveva molte criticità e stiamo riflettendo noi stessi sui possibili modelli alternativi per sistemarle, ma quella del cinema e dell’audiovisivo in generale è un’industria fatta in gran parte di lavoratori precari, che ha un grande e positivo impatto non solo culturale ma anche economico su tutto il paese, molto più di quanto non si racconti.