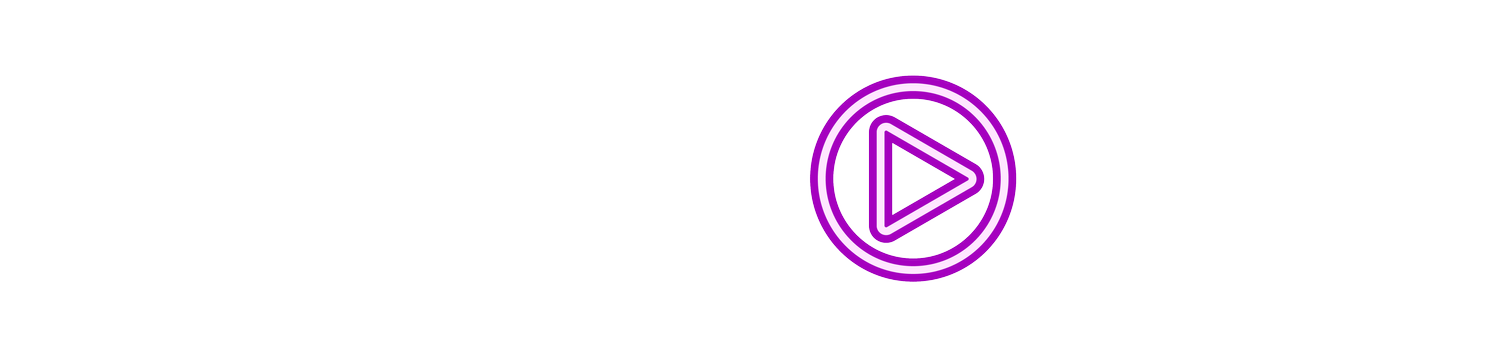Intervista a Sofia Assirelli – Episodio 1: essere headwriter in Italia
All’interno della collettività che caratterizza la produzione seriale, il lavoro degli sceneggiatori si colloca alla convergenza tra stimoli creativi, vincoli produttivi e logiche editoriali. Sofia Assirelli è sceneggiatrice da molti anni, ha lavorato a produzioni generaliste e streaming, tra cui La porta rossa (2017-2023) – serie noir ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, di cui è stata anche headwriter insieme a Rigosi –, L’ispettore Coliandro (2006-2021), Chiamami ancora amore (2021), Summertime (2020-2022) e Gerri (2025). Nel 2025 esordisce nel lungometraggio, scrivendo La vita da grandi, primo film da regista di Greta Scarano. L’abbiamo incontrata per parlare con lei della sua carriera e di cosa significa essere sceneggiatori televisivi oggi.
Come hai iniziato questo mestiere?
Diciamo che la storia inizia moltissimo tempo fa. Fin da quando ho memoria, io volevo scrivere – in particolare romanzi – ma ho saputo anche molto presto che non sarebbe stato facile fare della scrittura di narrativa un mestiere. Quando ero al liceo ho frequentato un corso di sceneggiatura con Giampiero Rigosi, che è anche un romanziere, e molto concretamente gli ho chiesto se campasse scrivendo libri. Lui mi disse che in gran parte il suo mestiere era fare lo sceneggiatore e lì allora ho pensato che la sceneggiatura potesse essere una strada per vivere di scrittura.
Anni dopo mi sono iscritta al Centro Sperimentale a Milano, era un corso sulla serialità televisiva, “Creazione e produzione fiction televisive”. È stata una scuola utilissima, anche perché, devo ammetterlo, non ho avuto il pallino per il cinema fino a pochi anni fa. Vengo da un paesino di trecento abitanti, dove il cinema ovviamente non c’era e la prima volta che sono andata al cinema ero già adolescente. Al contrario, avevo invece una grande passione per la televisione, per le serie televisive dell’epoca.
Ad esempio cosa guardavi?
Io guardavo veramente di tutto. Mi era vietato solo Twin Peaks, che mi terrorizzava. Oltre allo spazio per l’approfondimento molto maggiore rispetto ai film, quello che mi ha sempre attirato moltissimo delle serie è l’idea che ci sia un invito a tornare, e una scelta da parte dello spettatore di farlo ad ogni costo. In questo modo si instaura un rapporto intimo, simile a una relazione amorosa. Allo spettatore viene chiesta fedeltà e il creatore deve offrirgli il giusto mix tra sorpresa e soddisfazione. Questo, in casi estremi come Lost, può portare alla fondazione di una vera e propria comunità di fan, ed è una cosa che mi affascina tuttora, anche se adesso la moltiplicazione delle produzioni e delle modalità di fruizione rende più rari i veri e propri fenomeni seriali collettivi.
Inoltre, mi è sempre piaciuto l’aspetto popolare delle serie: il fatto che una serie arrivi a tante persone non mi è mai sembrata una cosa negativa, anzi. Quando ho cominciato a fare la sceneggiatrice, le serie erano ancora considerate da molti di serie B, C. Molti addirittura si vergognavano a dire che le guardavano! Adesso sembra impossibile, ma era così. Invece io ho sempre pensato che la serialità fosse principalmente un formato, che può essere utilizzato in mille modi diversi. Ora ho un’opinione un po’ più critica, nel senso che l’industria della produzione seriale è più complessa e stratificata di quella cinematografica, e quindi essere autoriali nella serialità è un po’ più difficile.
E poi dopo il Centro Sperimentale quali sono stati i tuoi primi lavori?
Alla fine del Centro Sperimentale ho fatto un tirocinio, in una writers’ room. Era l’ultima stagione dei Cesaroni e aveva una modalità di lavoro che non è mai più esistita, almeno in Italia: c’erano nove sceneggiatori, fissi per mesi e mesi lì, tutto il giorno. Allora di serie ce ne erano pochissime e ci si poteva permettere di avere così tanti sceneggiatori su un solo progetto. Per me è stata una palestra incredibile, perché sono stata lì sette mesi, ho seguito tutto il processo creativo, fino al set, e ho firmato il mio primo episodio insieme agli altri sceneggiatori. Nel frattempo era continuata la collaborazione con Giampiero Rigosi, e quando lui mi ha chiesto di scrivere insieme La porta rossa ho colto l’occasione per tornare a Bologna.
A partire dalla seconda stagione della Porta rossa sei diventata headwriter insieme a Rigosi. In Italia, quanta voce in capitolo ha l’headwriter nella realizzazione della serie? Esercita lo stesso controllo creativo degli showrunner nell’industria americana?
Per quanto riguarda la mia esperienza, io e Giampiero Rigosi nella Porta rossa non abbiamo partecipato attivamente alla produzione, ma c’è sempre stato un confronto creativo. Ad esempio, noi avevamo già finito tutte le sceneggiature quando ci hanno comunicato chi era il regista, Carmine Elia. È stato lui a pensare di ambientare la storia a Trieste, un apporto che noi abbiamo accolto molto volentieri. Ci hanno portato a Trieste e ci hanno fatto innamorare della città, che era perfetta per il progetto, adattandosi molto al tema del confine, del rapporto tra vita e morte. E noi quindi abbiamo riscritto tutte le sceneggiature ambientandole lì. Da quel momento, con lui abbiamo collaborato ancora di più, e per la seconda stagione abbiamo interagito già in fase di scrittura, e questo ha reso molto fluido il passaggio alla realizzazione.
In generale, è importante sottolineare che la fedeltà a ciò che hai immaginato non è un capriccio dello sceneggiatore, è l’unico modo per rendere uniforme e vero il mondo che racconti. Però in Italia non succede in maniera insita al ruolo dell’headwriter.
Non è ancora una cosa così istituzionalizzata, quindi.
Si ha voce in capitolo sulle scelte creative ancora in base alla possibilità che ti viene data dagli altri, in primis i produttori e i registi, ma non è una cosa automatica. È qualcosa per cui abbiamo molto lottato negli ultimi anni, con i sindacati e le associazioni di categoria – io sono iscritta a 100autori. Spesso adesso si ottiene il credito. Ma per la mia esperienza dipende proprio dalle persone con cui lavori e da come loro vedono il tuo apporto. C’è anche da dire che lo showrunner americano ha anche una formazione di tipo produttiva e quindi ha anche un ruolo di responsabilità di quel tipo, qui in Italia quel genere di formazione per tanto tempo non c’è stata, sta cominciando ad esistere negli ultimi anni, per il resto sono esperienze sul campo. Le cose stanno migliorando, ma c’è ancora molto da fare.
Questo dipende anche dal player con cui si lavora o è indifferente?
No, diciamo che c’è una lunga abitudine italiana, che è difficile da smantellare e che vale un po’ ovunque. Quando la serialità come la intendiamo oggi è arrivata in Italia si è ritrovata un sistema produttivo che non era del tutto pronto, quindi si sono applicati i modelli che esistevano già e che godevano di una lunga tradizione. In Italia c’era molto la visione del regista-autore, quindi i primi ad esercitare una visione autoriale di coordinamento sono stati proprio dei registi, altre volte i produttori, altre volte, ma meno, sono stati gli sceneggiatori. Un esempio più simile all’impostazione americana che mi viene in mente è Ludovico Bessegato [creatore di SKAM Italia e Prisma, n.d.r.]. Lui scrive, dirige e conosce bene anche la prospettiva produttiva. In generale, è tutto ancora molto in transizione, e si sta lavorando anche dal punto di vista sindacale per rendere tutto più omogeneo.
Mi viene in mente l’accordo siglato circa un anno fa tra Writers Guild Italia, l’associazione 100autori e Netflix per regolamentare il riconoscimento del credito “Creato da” in Italia.
Sì è una cosa molto recente, un traguardo molto importante. Ma non deve essere solo una semplice dicitura, deve essere effettivo.
Continua…