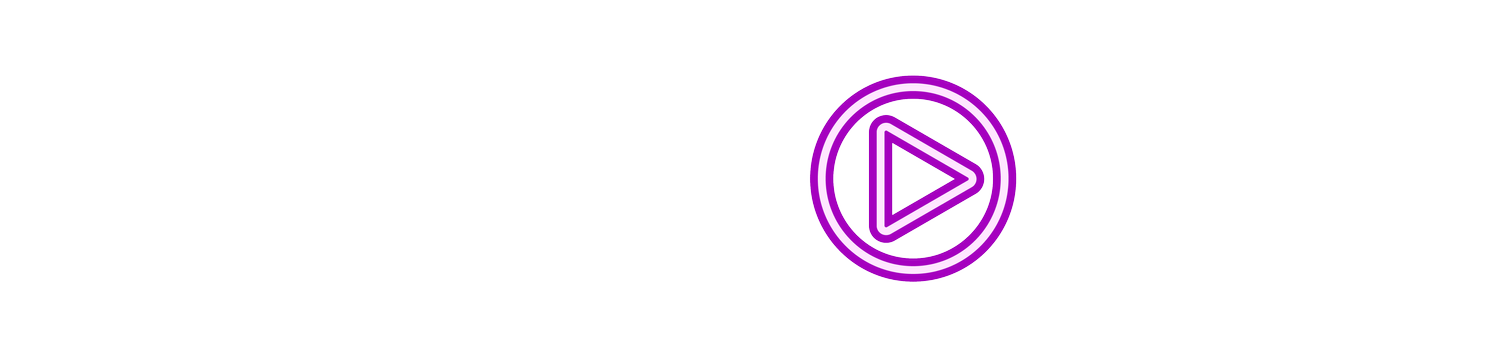Intervista a Filippo Gravino: artigiano radicale della scrittura cinematografica
C’è chi scrive per mestiere e chi scrive perché non può farne a meno. Filippo Gravino appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Sceneggiatore di alcuni tra i film e le serie più intensi del cinema italiano contemporaneo — da Una vita tranquilla ad Alaska, da Veloce come il vento a Il primo re, passando per Romulus e Fiore — Gravino racconta il suo mestiere come un atto di fedeltà assoluta alla vita, alla verità, alle storie che valgono la pena di essere narrate. Lo abbiamo incontrato per ripercorrere insieme le tappe fondamentali di una carriera costruita con etica, passione e una potente firma autoriale, capace di tenere insieme il realismo più feroce e l’epica più autentica.
Hai esordito come sceneggiatore con “Lascia perdere, Johnny!” nel 2007, lavoro in cui in cui inizia ufficialmente la tua collaborazione con Guido Iuculano con cui poi hai scritto i film di Claudio Cupellini “Una vita tranquilla”, “Alaska”, “La terra dei figli” e le serie televisive “Romulus” e “Vite in fuga”. Che ricordo hai di quel periodo?
Tutto è cominciato al Centro Sperimentale di cinematografia. Lì ho incontrato il mio maestro assoluto e definitivo che è stato Umberto Contarello, tre mesi con lui al centro sperimentale mi hanno forgiato nel marmo, grazie a lui ho stabilito regole ferree di etica, professione, qualità., Grazie Umberto, che tu sia lodato. Durante gli anni al centro sperimentale incontro sia Guido Iuculano che Claudio Cupellini. Guido è uno sceneggiatore straordinario, dotato di capacità per me inarrivabili, pochi come lui in giro, forse nessuno. Claudio Cupellini è il regista che speravo di incontrare, grande amore per le storie, i personaggi, è un regista narratore, come quelli che ho adorato da spettatore: Altman, Arthur Penn, Truffaut. Claudio è un regista meraviglioso. Con loro due si è creato un sodalizio che per me ha portato a film bellissimi, e forse al film a cui sono più legato tra quelli che ho scritto, che è Alaska, un film sottovalutatissimo e che a distanza di anni mi sembra meraviglioso.
Nel 2009 hai firmato l’esordio alla regia di Claudio Giovannesi, “La casa sulle nuvole”. Una collaborazione che poi è proseguita anche “Alì ha gli occhi azzurri” e con “Fiore”. Ti va di raccontarci qualche aneddoto legato a questa collaborazione?
Claudio Giovannesi è stato un altro fortunatissimo del mio percorso. Con lui abbiamo sperimentato un tipo di scrittura che mi ha fornito metodo e rigore. Un rapporto con il reale intenso che mi ha aiutato a formare la mia qualità di scrittura, soprattutto sul dialogo. Claudio è un regista che ha elaborato un metodo e seguirlo è una forma di cinema samurai che mi esalta. Un aneddoto che mi riporta a Fiore è un pomeriggio di primavera, da tre mesi per preparare il film incontravamo i ragazzi nel carcere di Casal del Marmo. E tornando in scooter dal carcere minorile ebbi una crisi di panico improvvisa. Tutto quel tempo in carcere con i ragazzi mi aveva portato sottopelle un disagio, che improvvisamente sgorgava fuori nel traffico di Pineta Sacchetti. Lavorare con Giovannesi è un processo potente di analisi del fuori che naturalmente porta ad un'analisi del dentro, che può provocare corto circuiti emotivi che o ti abbattono o ti spingono oltre. Un' esperienza di vita formidabile, ma ci vuole scorza dura.
Tra i tuoi meriti, dal mio punto di vista e non solo, c’è quello di aver riscritto la geografia del cinema italiano di genere. Cito i due lavori che hai fatto con Francesca Manieri, “Veloce come il vento” e “Il primo re”, due film in cui si percepisce un’urgenza realistica ma anche un respiro epico. Qual è il segreto per tenere insieme queste due componenti?
Francesca Manieri è un altro incontro fortunato del mio percorso. Tenere testa a Francesca è una forma di allenamento del cervello fortificante, è come portare il cervello a West Point. Matteo Rovere è la gioia del cinema, è la cosa più vicina a ciò che mi faceva saltare sulle poltrone del cinema quando guardavo E.T. o Flashdance. Lavorare con Rovere è godere. Poi sul genere io non ho tanto da dire. Mi chiedo per esempio se i miei film d'elezione siamo o meno. Il cacciatore è un film di guerra? Boh. Fargo è un crime? Boh. Un uomo da marciapiede è un buddy movie o una storia d'amore? Io so solo che raccontare soltanto ciò che ti circonda è una grande cazzata. Si può scrivere di qualsiasi cosa mettendoci dentro ciò che si conosce, questo sì!. Quindi io se scrivo di Romolo e Remo ci metto dentro me e mio fratello .Se scrivo come Pecore in mezzo ai lupi ci metto dentro una mia amica del liceo. Altro non so . Sulla teoria sono scarso, perdonami.
Il tuo 2025 è partito con il botto con due serie diverse tra loro ma ugualmente apprezzate: “ACAB - La serie”, sequel del film del 2012 di Stefano Sollima e “Storia della mia famiglia”, figlia di un’idea del produttore Nicola Serra ispirata a sua volta ai concetti di Michela Murgia. Come hai lavorato a questi due progetti?
Devo correggerti. Storia della mia famiglia non è un'idea di Nicola Serra, ma è un'idea mia. Nicola Serra di Palomar ha il grande merito di avermi chiesto di raccontargli storia che avrei voluto scrivere, e di averla sostenuta dall'inizio alla fine con un entusiasmo e una tigna di cui gli sarò grato per sempre. Acab e Storia della mia famiglia sono agli antipodi per concezione e percorso. Non so minimamente avvicinarle o cercare connessioni. So che ho dato l'anima per entrambe, e con me gli altri colleghi che ci hanno lavorato. Guardo le due serie e mi danno orgoglio, sono bellissime entrambe. Le ho scritte quasi simultaneamente, mi sono fatto un mazzo indimenticabile e alla fine ho avuto un crollo fisico ed emotivo. Qualcosa che non posso definire esaurimento nervoso, ma ci sono andato vicino. Ho deciso di smettere di lavorare per un lungo periodo, un periodo di assoluta felicità, non fare niente è meraviglioso. Poi mi sono accorto di non avere più un euro e purtroppo ho ricominciato a lavorare.
Come è cambiato il lavoro dello sceneggiatore da quando hai iniziato, considerando anche il lavoro di Sky (su tutte penso a una serie a cui hai lavorato come “Gomorra - La serie”) e l’avvento di piattaforme come Netflix, distributrice proprio dei tuoi due ultimi lavori da sceneggiatore?
La serialità ha portato lo sceneggiatore al centro del progetto. In Italia ci abbiamo messo dieci anni in più per capirlo, ma sai siamo un popolo che in anticipo non ci arriva mai sulle cose. Nella serialità è chiaramente fondamentale la narrazione, gli americani e gli inglesi lo sanno da vent'anni. In Italia pur di non metterci al centro, hanno messo al centro produttori, scrittori, registi, panettieri e idraulici. Poi hanno capito, intanto il tempo è passato veloce, e abbiamo perso occasioni. Più di questo io non so, mi dispiace, come ti dicevo di ragionamenti teorici non ne so fare. A me piace mangiare, bere, il Napoli, giocare a tennis e i Cure.
Per concludere ti volevo chiedere una cosa strettamente legata all’attualità e al futuro prossimo. Qual è la tua opinione sull’avvento dell’intelligenza artificiale (anche) sul mercato produttivo e cinematografico? Da sceneggiatore lo vedi più come un “nemico” da arginare o come un “alleato” che possa aiutarti nella scrittura?
Da quando c'è questa faccenda dell'intelligenza artificiale, scrivo in modo sempre più identitario, le mie sceneggiature sono mie, ho una grammatica mia, un ritmo, un tono, che so fare solo io, perché è personale, ma personale in modo estremista. Sono un "tupamaros", un Khmer rosso della mia scrittura, Voglio proprio vedere come cazzo fa chatgpt a scrivere come scrivo io.