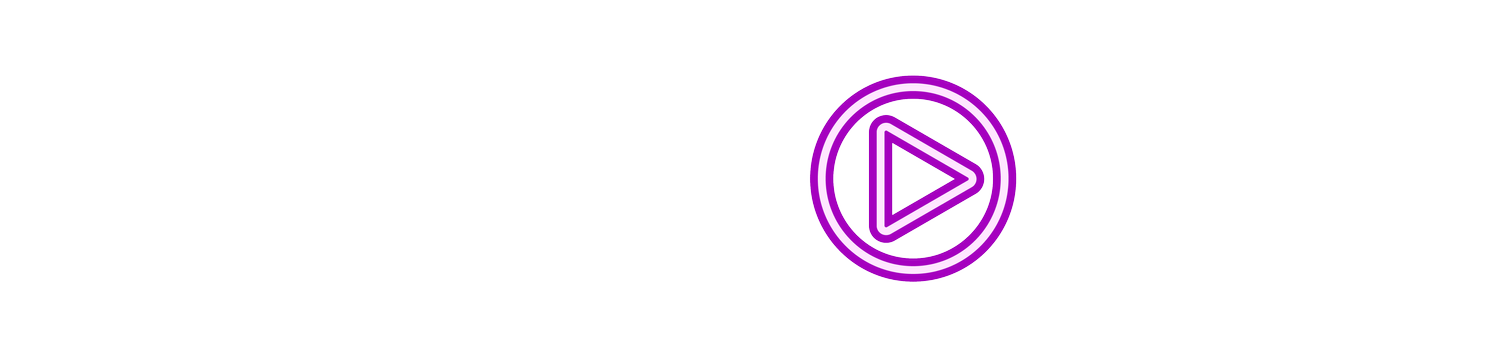“La città proibita” di Mainetti: spaghetti kung fu tra cliché e ambizione mancata
Gabriele Mainetti dopo alcune prove d’attore e svariati cortometraggi (per testare il proprio linguaggio registico), ha esordito nel lungo con Lo chiamavano Jeeg Robot, venendo immediatamente osannato da gran parte del pubblico e della critica. Mainetti inserisce nel corpus della commedia borgatara il cinecomic e ne esce un crossover ironico e intelligente, una boccata d’ossigeno per l’asfittico panorama del cinema italiano di genere.
Peccato che, per chi scrive, l’originalità di scrittura e di messa in scena del cineasta romano si esauriscono qui. Nel 2021 Freaks Out, sempre su soggetto del fido Nicola Guaglianone, cerca di alzare il tiro con la presunzione di voler riscrivere la Storia (non solo del cinema) su modello di Tarantino.
Il gigantismo cinematografico di Mainetti è lodevole dal punto di vista progettuale ma assai deludente per quanto concerne gli esiti realizzativi.
Lo stesso problema si presenta con il film appena uscito su Netflix, La città proibita (titolo omonimo a quello italiano di un wuxia pian di Zhang Yimou), fatto nel tentativo di resuscitare lo spaghetti kung fu, filone molto in voga negli anni Settanta.
La struttura narrativa è pressoché identica a quella dei precedenti lungometraggi.
Un personaggio dai poteri eccezionali che si scontra con la quotidianità depressa e incarognita delle borgate romane. Qui la protagonista è Mei, ragazza cinese campionessa di arti marziali, che si ritrova in una Roma multietnica in cui incrocia il proprio destino con quello di un giovane cuoco e con un losco giro di prostituzione.
L’umorismo è principalmente di situazione, inserendo un personaggio in un contesto a lui completamente estraneo, creando così una commistione tra la romanità più trucida ed elementi della cultura cinese, specialmente l’arte del kung fu.
Nulla di nuovo se pensiamo che L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente si svolge proprio a Roma e l’epico scontro tra Bruce Lee e Chuck Norris avviene nel Colosseo, a cui poi ha fatto seguito lo strepitoso Ku-Fu? Dalla Sicilia con furore. Nella parodia con Franco Franchi, la cultura cinese viene riprodotta all’interno di Trastevere e secondo Tommaso Labranca lo spirito trash del film vive di un sano eclettismo e di una revisione postmodernista. Una genuinità di sguardo ironico che non appartiene a Mainetti, troppo concentrato sulla magniloquenza di set e scenografie, restando così intrappolato nel sogno colossal di un’idea di cinema nobile, ma ingenua nei risultati.
La città proibita si consuma e si gode solamente nella sua confezione, senza possibili letture trasversali, scontando a più riprese una certa ripetitività da cliché capitolino (Sabrina Ferilli un po' sprecata) e maldestre incursioni nel melodramma familiare.
I personaggi non sono mai approfonditi fino in fondo, risultando dei semplici bozzetti inseriti in un sontuoso impianto dove dominano le tonalità rosso rubino e dei gustosi combattimenti comico-feroci, non esenti da qualche risvolto slasher.
Il bozzettismo funziona nella caricatura allo stato puro, ma non in operazioni come questa che guardano a una drammaturgia più complessa.
Mainetti fa dell’artigianato di genere (come lo si chiamava un tempo), un bignamino epidermicamente seduttivo e anodino. Mancano l’umiltà e la veracità dell’autentico cinema bis, replicando idee e situazioni pregresse, tra canzoni italiane di culto (Giallini che canta De André è il copia e incolla di Marinelli che canta Anna Oxa in Jeeg Robot) e trovate narrative che sembrano uscite da un episodio de L’ispettore Coliandro di vent’anni fa.
Il film è stato girato nel rione popolare Esquilino, già sfruttato tre anni fa dal farsesco Grosso guaio all'Esquilino - La leggenda del kung fu, con protagonista Lillo Petrolo.