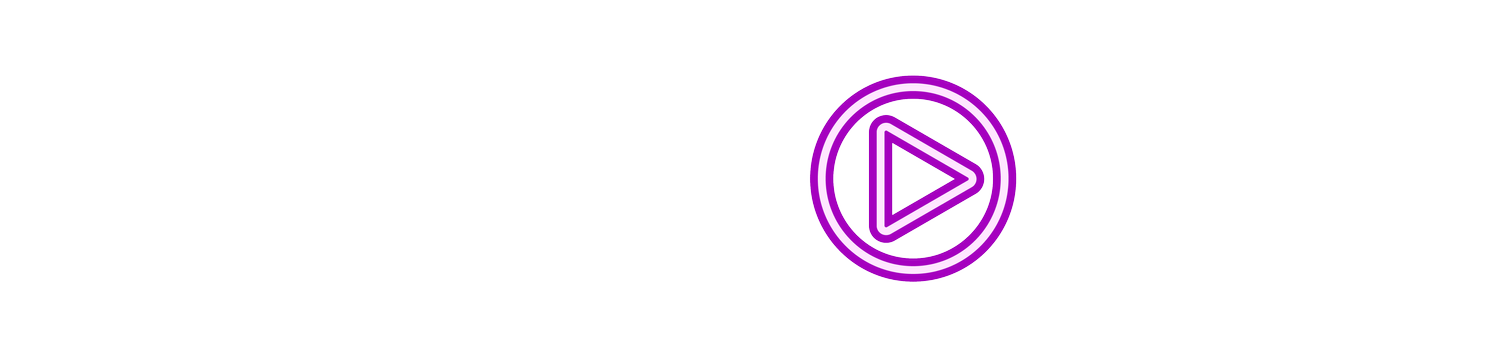Il tempo che ci vuole - Tributo e ringraziamento per Fabrizio Gifuni parte 2
«A me da quel giorno mi è cambiata la vita. Perché io ho capito che con il Cinema potevo scappare, hai capito? Con l’immaginazione».
Pochi film hanno la dote di riuscire a commuovere nel profondo basandosi sulla forza inestimabile e al “potere immaginifico” e salvifico delle immagini in movimento, rendendoci partecipi completamente della condivisione dettata dall'esperienza filmica nel suo creare e raccontare vite. Soprattutto se queste vite sono quelle di coloro che nel Cinema ci hanno creduto, che hanno scelto di vivere lì in quel quadrato di luce e nella magia che si instaura nelle dinamiche di un set cinematografico, il veicolo delle emozioni che dà linfa ad un altro modo possibile di poter vivere, questo è la forza più completa dell’Arte. E questo è quindi il caso di Luigi Comencini e di Francesca Comencini e de Il tempo che ci vuole, opera autobiografica della regista che racconta scrupolosamente il rapporto con suo padre, una delle voci più grandi del nostro cinema: Pane, amore e fantasia, Lo scopone scientifico e soprattutto il film televisivo Le avventure di Pinocchio. Quest’ultimo un film segnante per tanti motivi, dall’uso neorealista della favola collodiana anche nell’estetica della messinscena, e da sequenze memorabili quali quella del pescecane o del Gatto e la Volpe, nonché dalla sua non celata malinconia, da un senso di inadeguatezza e di continuo smarrimento ma anche di grande magia e stupore quasi felliniani. È proprio la lavorazione de Le avventure di Pinocchio ad occupare la prima parte de Il tempo che ci vuole, ed infatti vediamo immediatamente la Comencini bambina (interpretata dalla giovanissima e bravissima Anna Mangiocavallo, per la prima volta sullo schermo) che viene coinvolta per filo e per segno da suo padre Luigi nelle atmosfere di quel film magico: la paura che lei prova per la figura ancora solo illustrata della balena, a rispondere su quale fosse il suo personaggio preferito di Pinocchio (lei risponderà Lucignolo e su cui Comencini padre le dirà che è un bellissimo personaggio, e che nessuno nasce cattivo, Lucignolo vuole solo essere libero), portandola finanche sul set, facendo respirare alla bambina davvero un mondo altro, diverso dalla realtà, e nonostante il grande regista si preoccupa di dire al suo assistente durante un momento di tensione sul set: “Prima la vita, poi il Cinema”, in realtà quello che crede Comencini è a parer mio il contrario.
Il film vuole restituirci, comunque, non un freddo ed oggettivo biopic ma un appassionato scavo negli affetti e nelle personalità di queste due persone che camminano insieme guardandosi e specchiandosi nei loro occhi grandi, nel loro rapporto padre-figlia e dall’amore eterno per il Cinema, quest’ultima una passione e un’ossessione che la giovane Francesca divenuta teenager decisamente problematica (interpretata da Romana Maggiora Vergano) ancora non sa che tratteggerà anche la sua di strada. Un film fondato su una sobrietà, su una delicatezza ma anche da una dose altamente drammatica, scioccante in alcuni momenti, non poteva che fondarsi su un interprete dotato di queste sensibilità e questo rispetto e Fabrizio Gifuni, perennemente in scena nelle vesti e nel corpo di Luigi Comencini anche attraverso i decenni (tra l’altro lavoro straordinario del reparto make-up), porta con sé quella gentilezza, una cordialità e un amore per la figlia futura regista davvero senza fine. Oltre alla scena conclusiva del film che non voglio svelare nei dettagli ma che per me è già cult fuori dal tempo, ho percepito una verità nei sentimenti in due particolari sezioni de Il tempo che ci vuole: quando Francesca teenager vede suo papà Luigi arrancare per una lunga scalinata quando i segni della vecchiaia del regista si fanno sempre più presenti, e non può credere che sia realmente affaticato ma stia facendo finta (“Tu sei sempre stato un camminatore, mi stai prendendo in giro”) e Fabrizio Gifuni nella sua espressività ci ridà tutto quel senso di sacrificio e di amore mentre il personaggio di Francesca Comencini non riesce a mettere a fuoco: per lei la presenza e la forza di suo padre non può e non potrà mai soccombere; è una piccola scena che racconta molto e che mi ha letteralmente fatto esplodere il cuore. Poi, il secondo momento è il racconto di un altro amore, quello per il Cinema, di come è cominciato tutto per Comencini: la “colpa” è di un film del 1932 di G.W. Pabst, L’atlantide che per puro caso e per via di un appuntamento mancato, il giovanissimo Luigi vede al Cinema a Parigi. E quando Fabrizio Gifuni racconta con la sua voce profonda, chiara e ferma questo suo antico innamoramento, sullo schermo vediamo comparire la bellezza ammaliatrice di Brigitte Helm, l’interprete della Regina Antinea del film. Noi, dunque, diveniamo parte di quell’incantesimo, ci innamoriamo perdutamente e realizziamo di quanto sia grande il potere del Cinema, così come quando vediamo successivamente nel film, Luigi Comencini commuoversi e lacrimare senza freni quando in televisione per puro caso rivede una delle sequenze più memorabili di Paisà di Roberto Rossellini.
Il tempo che ci vuole è un film che fa dell’intensità il suo aggettivo principe e che mostra perdutamente quanto i legami siano delle catene, a volte anche dolorose ma anche e soprattutto capaci di aiutarci e tenerci stretti e strette attraverso il viaggio della vita, e per questo perderci per poi ritrovarsi, cercando tra la folla le espressioni gentili del Luigi Comencini di Fabrizio Gifuni che ci dona una serenità e una pacatezza che risulta difficile, quasi impossibile, far girare fra le dita e rendere quotidiana in questo mondo attuale. La positività che cela questa vicenda umana ci fa sentire al sicuro e vederlo è un viaggio bellissimo, così come spontaneamente recita la Francesca bambina durante una scena sul set di Pinocchio. E la bontà, poi, di alcune immagini finali ci riscaldano, come quando Francesca ormai divenuta anche lei regista e collabora con il padre ormai visibilmente anziano su un set (probabilmente dal film Marcellino pane e vino, 1991) e lui le dà delle indicazioni di regia, questi sono limpidi insegnamenti su come fare Cinema (“Devi girare sempre i totali. I totali sono importanti, fanno capire agli spettatori dove sono i personaggi e dove siamo”), o almeno come era il vero mestiere del regista cinematografico prima dell’avvento della totale immersività e dell’esclusività del primo piano. Comencini è stato un regista che metteva sopra ogni cosa la bellezza di raccontare una storia, che non era però la sua personale, e aveva un rispetto profondo per il pubblico perché pubblico lo era lui stesso innanzitutto, e pertanto il suo cinema recava un forte timbro popolare e grande chiarezza espositiva, e per questo funziona tutt’oggi anche a livello sentimentale. Per Francesca Comencini non deve essere stato assolutamente facile donarci tutti questi pezzetti della sua vita e del suo rapporto con suo padre, quest’opera possiede una preziosità rara, noi dobbiamo conservarla e tenerla stretta a noi così come sono certo che continuerà a fare lei aiutata dallo sguardo giocoso, amorevole e denso di Fabrizio Gifuni che in questa quieta e rassicurante performance arriva addirittura a scontrarsi con la maestra di scuola della piccola Francesca perché lui “crederà sempre ai bambini”, e al valore infinito dell’immaginazione.
Permettetemi una chiusa personale, a questo punto. Ho avuto la fortuna in questi ultimi anni di ricevere il dono frequente della personalità di Fabrizio Gifuni all’interno della mia città, Lucera, situata in provincia di Foggia. L’attore, oltre ad essere molto presente sul territorio durante il periodo estivo, viste le sue origini, ha ideato e diretto con Natalia Di Iorio a titolo assolutamente gratuito a partire dal 2017 la stagione teatrale “PrimaVera al Garibaldi” portando nella mia piccola città (presso il Teatro Garibaldi e l’Anfiteatro augusteo) personalità del calibro di Toni Servillo, Isabella Ragonese, Antonio Rezza, Flavia Mastrella, Sonia Bergamasco, Vanessa Scalera, Lino Musella, Elio Germano e tantissimi altri, regalando emozioni meravigliose, come potrete intuire. Purtroppo però la magia si è spenta, inaspettatamente e non per volontà di Fabrizio, anzi. Lui anche quest’ultima estate che sta volgendo al termine era pronto a portare nuovi spettacoli e personalità artistiche in questa città di nemmeno trentamila abitanti della Puglia, ha mostrato una dedizione profonda al tessuto di Lucera, tanto da prestare volto e voce al discorso di candidatura di Capitale della Cultura 2025 presso il Ministero della Cultura, ma si sa che spesso le amministrazioni e le politiche locali non sono assolutamente lungimiranti, si fregiano di nomi di cui ignorano il significato più profondo e disperdono e sradicano quelle che potevano essere radici spesse e forti, e l’inizio di un percorso vero di accrescimento culturale, nel senso più autentico della parola.
Questo, perciò ed infine è anche un mio piccolo brano di tributo e di ringraziamento per Fabrizio Gifuni, per la sua arte e per il suo essere così senza riserve un uomo e un interprete positivo dal cuore buono e fonte di una statura intellettuale così grande come questi suoi due personaggi di cui abbiamo dibattuto, Aldo Moro e Luigi Comencini.