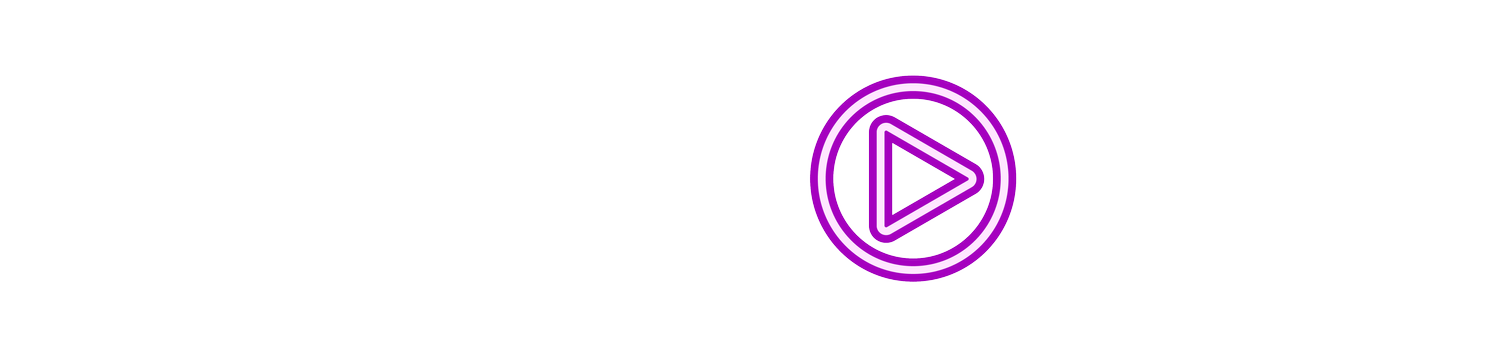Il Mostro: il buio che continua a guardarci
Il Mostro di Firenze non è mai stato soltanto un assassino, ma una ferita che si riapre ogni volta che il suo nome viene evocato. Una ferita che appartiene alla cronaca ma, più ancora, all’immaginario collettivo. Con Il Mostro, Netflix e Stefano Sollima affrontano questo abisso scegliendo di non inseguire una verità definitiva, ma di moltiplicare i punti di vista: quattro episodi, quattro sospettati, ognuno al centro del proprio racconto. Ogni episodio smentisce o ribalta il precedente, trascinandoci in un territorio in cui la verità è sempre provvisoria, fragile, quasi impossibile da afferrare.
Il cuore narrativo è la cosiddetta pista sarda, l’ipotesi investigativa che per decenni ha dominato le indagini. Tutto parte dall’omicidio del 1968 a Signa, in cui vennero uccisi Barbara Locci e il suo amante Antonio Lo Bianco mentre in auto c’era anche il figlioletto di lei, sopravvissuto. Per quel delitto fu condannato il marito Stefano Mele, ma da subito gli inquirenti sospettarono che non avesse agito da solo. Da lì si aprì il capitolo dei “sardi di Firenze”: una cerchia di uomini legati a Locci – tra cui Francesco Vinci e Salvatore Vinci – che negli anni furono a turno indagati e arrestati come possibili responsabili dei delitti del Mostro. Nessuna prova definitiva li collegò mai, ma la pista rimase il fulcro delle ipotesi, con il sospetto di un gruppo che agiva in combutta. È proprio questo groviglio di gelosie, rancori e ombre familiari che la serie sceglie di portare in primo piano, raccontandolo non come un semplice retroscena processuale ma come il cuore pulsante di una tragedia corale.
Quello che funziona davvero è la capacità di trasformare il giallo in un discorso più ampio: gli omicidi diventano lo specchio di un’Italia patriarcale, un paese in cui la libertà sessuale e individuale delle donne veniva percepita come una minaccia da reprimere. Non c’è quindi solo il Mostro come figura criminale, ma un intero contesto culturale che si rivela mostruoso. In questo senso la serie ha il merito di spostare lo sguardo dal semplice true crime a una riflessione politica e sociale, restituendo la sensazione di una tragedia che riguarda tutti.
Sollima sceglie un registro austero, distante dal sensazionalismo. Le sue inquadrature insistono sui volti segnati, sugli interni claustrofobici, sulle campagne immerse in un silenzio che non consola. La fotografia gioca con i chiaroscuri e i toni smorzati, sottolineando l’ambiguità morale dei personaggi, mentre il ritmo narrativo predilige l’attesa, il sospetto che cova sotto la superficie. È un racconto che si muove tra psicologia e simbolismo più che tra azione e spettacolo. E in questo si avverte un respiro universale: il Mostro non è solo una vicenda italiana, ma l’incarnazione di un terrore collettivo, di quelle zone oscure che ogni società preferisce non guardare. È un racconto che parla di noi, e non solo di un assassino.
Non tutto, però, trova la stessa forza. La recitazione è spesso trattenuta, gli attori sembrano bloccati dentro una rigidità che raffredda l’emozione. La tensione, che dovrebbe scorrere come un fiume sotterraneo, a volte si affievolisce, e la scelta di contenere così tanto il pathos rischia di sacrificare la potenza drammatica di una materia che avrebbe meritato vibrazioni più forti. È come se la serie si fosse posta il compito di non cedere mai all’eccesso, ma in alcuni momenti questa misura diventa limite.
Resta comunque un’opera necessaria. Il Mostro non è una serie che si guarda per “sapere come va a finire” – perché non finisce, non può finire. È una serie che ci costringe a specchiarci in una delle nostre ombre più nere, e a fare i conti con il fatto che quell’ombra, in fondo, non se n’è mai davvero andata. Il Mostro non è mai stato solo un uomo: è il riflesso di un Paese intero, che da quella ferita non si è ancora liberato.