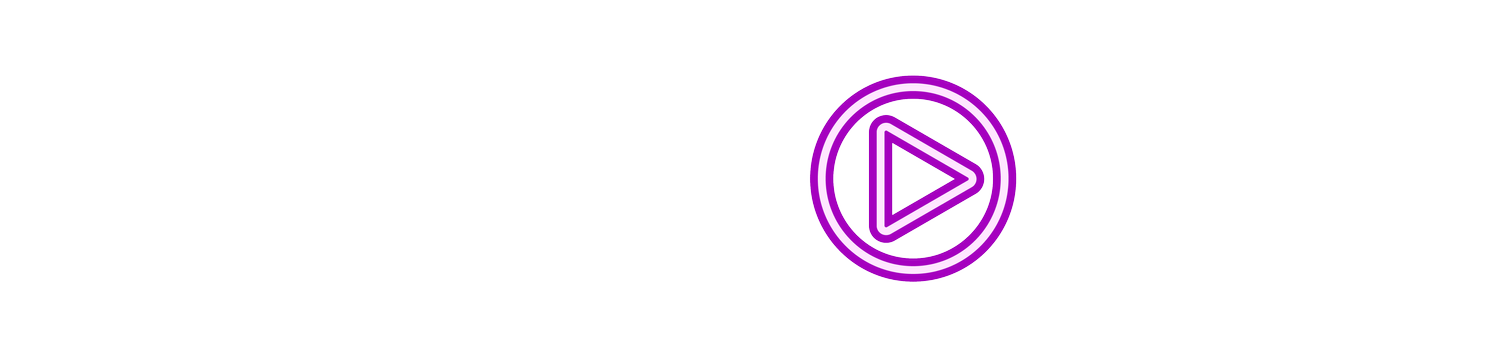Una terapia di gruppo: l’analisi nel cinema italiano
La coscienza legata alla salute mentale e alla terapia pare una delle poche azioni positive che i media contemporanei – tra cui anche la televisione, si veda Normal People (BBC, 2020) – son stati capaci di incentivare. Il cinema – perlomeno, quello italiano – pare tuttavia reazionario da questo punto di vista: si veda il caso di Una Terapia di Gruppo.
Remake dello spagnolo Toc Toc (Vincente Villanueva, 2017), Una Terapia di Gruppo – disponibile su NOWTV - è una commedia italiana del 2024 scritta e diretta da Paolo Costella. Racconta le vicende di un gruppo di individui che si ritrova in una sala d’attesa di uno psichiatra: persone (tra gli altri, Claudio Bisio, Margherita Buy, Valentina Lodovini e Claudio Santamaria) affette da OCD, che si manifesta in modi diversi, dalla Tourette all’ossessione per la pulizia, passando per la FOMO e aritmomania. A causa di un errore nella prenotazione, avvenuta via app, il gruppo si ritrova nell’attesa di beckettiana memoria di un dottore e, dunque, a cercare di mettere insieme una improvvisata terapia di gruppo per affrontare i propri problemi.
La pellicola si presenta come un’opera di evidente stampo teatrale, come dimostrano la singola ambientazione e la dimensione corale della sceneggiatura, in cui ogni personaggio sviluppa ogni suo arco con una scena madre per attore o attrice. A differenza di altri film con simile impianto, però, Una Terapia di Gruppo non impiega mai in modo significativo i mezzi espressivi tipici del cinema, affidandosi in maniera esclusiva alla sceneggiatura e al cast per la sua costruzione - una consuetudine “molto italiana”, direbbe La Rochelle. La stessa sceneggiatura, poi, fallisce nel costruire una narrazione in grado di divertire e intrattenere – chi scrive non ha riso una volta per le cose per cui il film voleva che lo spettatore ridesse, ma la risata, ça va sans dire, è una questione soggettiva.
Il vero fallimento di Una Terapia di Gruppo, tuttavia, risiede nel lato più informativo e divulgativo rispetto alla salute mentale. Quello che dovrebbe essere il tema centrale della pellicola, infatti, viene affrontato nella pellicola ricorrendo a tutti gli stereotipi che negli anni in Italia si sono venuti a creare sulla malattia mentale e sulla terapia. Per fare un esempio, similmente ad un altro prodotto recentemente sbarcato su piattaforma, Sconfort Zone (Prime Video, 2025), la terapia viene vista come una vera e propria trappola in cui la persona cade in inganno: per quanto poi possa diventare uno strumento di crescita per i protagonisti, questi devono essere raggirati e presi in giro per avviare tale percorso. L’identità nella rappresentazione della terapia nei due prodotti è tale che condividono lo stesso colpo di scena narrativo – nella serie rivelato a metà del prodotto, nel film in esame invece è riservato come twist finale.
Va da sé, ovviamente, che i prodotti cinematografici - soprattutto se di carattere intrattenitivo - non devono necessariamente essere moralmente retti ed educativi a tutti i costi. Tuttavia, nel momento in cui si nota, come in questo caso, una stereotipizzazione continua e ripetuta dello stesso fenomeno, va quantomeno segnalata, discussa e, come in questo caso, problematizzata. I motivi per cui nel nostro Paese si insiste ad avere una simile visione di una pratica che ogni giorno salva migliaia di persone son sicuramente vari e sfaccettati; tuttavia, per chi scrive risulta necessaria un’inversione di rotta, anche solo per riuscire a restituire al cinema popolare una visione più sfaccettata (e meno dannosa) del mondo in cui viviamo.